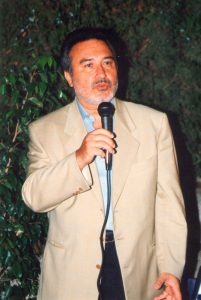Il Referendum di ottobre ha le condizioni per sancire una svolta istituzionale dello stato o si rischia un' involuzione antidemocratica?
“Il referendum ha per oggetto una legge di riforma della Costituzione di eccezionale portata e la soluzione del problema se può determinare un’involuzione antidemocratica dipende dal risultato dell’analisi degli effetti che ne possono derivare nel contesto istituzionale e, in primo luogo, nel funzionamento concreto del potere legislativo in primo luogo, in quanto oggetto diretto della riforma”.
Snellendo l'iter legislativo si rischia di ridurre la forza politica del dibattito parlamentare rafforzando eccessivamente i poteri del Governo?
Entrando nel merito del significato e della portata dello snellimento, viene in considerazione il testo della legge costituzionale 12 aprile 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, che reca “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
L’art. 1 della legge nel definire le “funzioni delle Camere”, stabilisce che “la Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato di governo”.
Per contro, “Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e…Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione (le altre funzioni sono di raccordo, valutazione, verifica ed espressione di pareri).
I casi e le modalità del concorso del Senato nella funzione legislativa sono elencati nell’art. 10 della legge di riforma costituzionale, riguardante il Procedimento legislativo, che sostituisce il testo precedente dell’art. 70 della Costituzione.
Al di là di importanti ma molto limitate materie, nelle quali “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, il Senato è escluso dalla funzione legislativa, perché “Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati”.
E’ quanto basta per concludere che la legge di riforma ha sostanzialmente trasformato il parlamento da bicamerale paritario a monocamerale.
Né possono incidere su questa conclusione le disposizioni dei commi 3 e seguenti del citato art. 10 della legge di riforma per cui il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può decidere di esaminare i disegni di legge approvati dalla Camera entro dieci giorni dalla trasmissione, avendo trenta giorni successivi per deliberare proposte di modifica, dalle quali la Camera può discostarsi con l’approvazione in via definitiva a maggioranza assoluta.
Infatti il quorum per la richiesta di esame è eccessivo e i termini sono evidentemente troppo esigui perché l’intervento del Senato – peraltro al solo fine di dare un voto puramente consultivo e successivo all’approvazione della Camera – possa tradursi in una funzione concretamente e stabilmente esercitabile. Si conferma anche per questo aspetto che il Senato sostanzialmente escluso dal potere legislativo.
Ora, fermo restando che il sistema bicamerale perfetto, in quanto fondato sulla deliberazione conforme di due camere praticamente non differenziate, rallenta eccessivamente l’espletamento della funzione legislativa senza fornire in cambio un valido contributo valutativo, è innegabile, tuttavia, che il contrario del bicameralismo perfetto è il bicameralismo imperfetto - cioè esercitato da due camere diversamente composte ma con competenza legislativa concorrente - e non il monocameralismo.
Questi essendo il contenuto ed il significato dichiarati della riforma costituzionale adottata, quali risultano dal testo del provvedimento legislativo che assegna la funzione legislativa e la conseguente fiducia al governo alla sola Camera dei deputati, rispondo alla Sua domanda dicendo che non si può più parlare di bicameralismo, neppure imperfetto.
Resta da valutare se lo snellimento dell”’iter” legislativo così ottenuto comporti effettivi vantaggi nella prospettiva di funzionamento nella concreta realtà attuale del nostro Paese”.
Su quali elementi si fonda, a Suo avviso, la valutazione degli effetti concreti, vantaggiosi o svantaggiosi, della riforma?
“La valutazione si fonda su due aspetti essenziali. Il primo riguarda la percentuale degli elettori che esprime effettivamente la propria scelta recandosi a votare. Percentuale che, almeno di regola e nel momentoattuale, non supera il 60% degli aventi diritto. Nella valutazione politica di quel rilevante 40% che diserta le urne, così prossimo alla metà degli elettori. non si tiene alcun conto. Ci si limita a qualificarli complessivamente come antipolitica e a demonizzarli come sovversivi, radicali, espellendoli dalla valutazione del consenso politico, limitato a quello espresso dai cittadini buoni, che invece sono andati a votare. Con un’operazione squisitamente politica che omette di considerare che in realtà non di sovversione si tratta, bensì di dissenso politico, di cittadini che non si sentono rappresentati e rifiutano il sistema, ritenendo ininfluente la propria partecipazione alla votazione e quindi inutile dare un voto che non consente in realtà, per i limiti in cui è contenuto, di esprimere una scelta effettiva. Di questo dissenso, a mio avviso, bisognerebbe invece tenere il debito conto nel momento in cui si riforma la legge fondamentale e uno dei poteri dello Stato, dandosi carico delle disfunzioni che lo determinano che possono genericamente compendiarsi nell’impenetrabilità di un sistema elettorale che tende sempre più a restringere l’ambito di espressione della volontà e, quindi, della libertà dell’elettore (penso al procedimento di formazione delle liste, ai capilista bloccati, all’eliminazione del voto di preferenza e così via).
Non resta quindi che prendere atto che nell’attuale sistema la maggioranza assoluta con cui si governa è del 31% degli elettori. Con tutte le conseguenze che se ne devono trarre in ordine al grado di rappresentatività della classe politica e della democraticità dell’intero sistema”.
Il secondo aspetto?
“Il secondo aspetto è che in una democrazia parlamentare, e nella nostra in particolare, il governo non solo deve avere la fiducia del Parlamento – e, quindi, secondo la riforma sottoposta a referendum, della sola Camera dei deputati - ma ne è anche espressione, nel senso che sia il presidente del consiglio dei ministri, che i ministri e i sottosegretari sono emanazione delle medesime forze politiche che costituiscono la maggioranza parlamentare.
 Basti considerare che oggi i membri del governo più influenti e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri sono anche segretari dei partiti politici che reggono la coalizione di maggioranza parlamentare e gli altri sono o deputati e senatori o esponenti dei medesimi partiti.
Basti considerare che oggi i membri del governo più influenti e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri sono anche segretari dei partiti politici che reggono la coalizione di maggioranza parlamentare e gli altri sono o deputati e senatori o esponenti dei medesimi partiti.Lo stesso avverrà quando ci sarà una sola camera perché il monocameralismo non elimina, e anzi accentua questo stato di cose, nel quadro di una legge elettorale maggioritaria che, così come è stata realizzata dopo il corrispondente referendum, non assegna alla minoranza alcun potere codificato *.
Sicché col 31% dei voti la maggioranza parlamentare cumula tutti i poteri legislativi e amministrativi dello Stato.
Ne risulta un’accentuata verticizzazione del potere statuale con conseguente rarefazione del rapporto dei cittadini con le istituzioni pubbliche e ulteriore peggioramento dell’attuale, profonda crisi di rappresentatività.
In tale contesto come si fa a dire che la doppia deliberazione (s’intende, in regime di bicameralismo imperfetto, diverso da quello attuale che resta comunque da riformare) di due camere a competenza legislativa concorrente non costituisca un contrappeso, cioè un momento di controllo? Controllo che si riconosce invece senza discussioni ai poteri del Capo dello Stato, della Corte Costituzionale e della Magistratura, benché esterni al procedimento legislativo”.
I costi della politica si ridurrebbero notevolmente. Quanto incide questo aspetto sulla portata della riforma costituzionale?
“La riduzione dei costi della politica è una conseguenza talmente indiretta e remota che non può considerarsi di significativa influenza su una riforma di quella portata.
Al riguardo sono comunque da fare alcune riflessioni.
In primo luogo la remunerazione dei parlamentari non è l’unica voce di “costo della politica” superfluo da eliminare.
Gli sprechi legati alla gestione politica del Paese sono tanti, così diversi e ingenti e tanto indipendenti dal trattamento economico direttamente corrisposto ai parlamentari che i risparmi della riforma costituzionale appaiono anche sotto questo aspetto del tutto secondari.
Ma quel che più conta è che la riduzione del numero dei parlamentari non è di per sé un bene. Tale numero non è aumentabile o riducibile a discrezione, ma ha una sua costante precisa in relazione al grado di rappresentatività che l’istituzione deve avere per garantire la partecipazione politica e democratica a tutti cittadini nel territorio nazionale.
Così impostata correttamente la questione, la superfluità o meno del numero dei parlamentari costituisce un aspetto della riforma da valutare nel “referendum” per verificare se la riduzione sia effettivamente giustificata da un numero eccessivo di esponenti o se invece non sia conseguenza della “semplificazione” della funzione legislativa dovuta all’introduzione del monocameralismo. In questo secondo caso c’è da chiedersi ulteriormente se il ridotto numero di parlamentari non incida negativamente sulla rappresenta del parlamento, divenuto monocamerale”.
Le Regioni ‘sacrificano’ buona parte delle proprie materie legislative in favore dello Stato. Un punto di forza o un vulnus della riforma?
“Quello della determinazione dei limiti dell’autonomia regionale è un problema da affrontare comunque, a prescindere dalla riforma costituzionale Le regioni non sono stati indipendenti e il nostro non è uno stato federale ma delle autonomie, sicché tanti poteri regionali, a partire dalla pretesa insindacabilità del bilancio e dall'eccesso di legislazione esclusiva suscettibile di degenerare in caos amministrativo, devono essere riconsiderati.
Mi pare che la riforma vada in questa direzione, peraltro assicurando all’autonomia regionale la garanzia derivante dalla nuova configurazione e dalle nuove competenze del Senato”.
Così com’è strutturata la riforma è senza dubbio complessa: non sarebbe stato meglio 'sezionare' i quesiti referendari?
“A mio parere il problema non sta nel numero e nel frazionamento dei quesiti referendari, che potrebbero anzi dar luogo a ulteriore confusione. Il problema e dell’effettiva consapevolezza da parte dei cittadini dei termini della scelta che compiono, scelta che riguarda la forma di stato che intendiamo adottare perché riacquisti la funzionalità che quotidianamente gli rimproveriamo di non avere. Conoscenza e consapevolezza necessarie soprattutto a noi Calabresi, che dobbiamo dimostrare – in primo luogo a noi stessi – di aver capito che i problemi nazionali sono problemi nostri non meno di quelli strettamente locali. E di sapere e volere dare il nostro contributo essenziale alla soluzione di essi, per uscire dalla condizione di sottosviluppo e di subordinazione politici e culturali in cui anche per nostra responsabilità ancora ci troviamo”.
La nuova legge elettorale “Italicum”,in che misura La convince e su quali aspetti non la trova d'accordo?
“La nuova legge elettorale 'Italicum' non mi sembra ideale, ma meno che mai mi convinceva quella battezzata con notevole disinvoltura dallo stesso autore come ‘Porcellum’.
In particolare, non mi sembra compatibile col rispetto della volontà dell’elettore l’attribuzione dei cosiddetti premi di maggioranza.
Sarei favorevole a una legge elettorale proporzionale analoga a quella vigente in Germania, con alte soglie di ammissibilità per evitare la frammentazione del sistema e, naturalmente, con eliminazione delle famigerate liste civiche, la cui inarrestabile proliferazione falsa la logica del sistema elettorale.
Passando alla valutazione dell’incidenza dell’Italicum sulla riforma costituzionale, dico subito che l’influenza della legge elettorale sul funzionamento del parlamento mi pare del tutto scontato. Basta considerare l’influenza nefasta che ha deliberatamente avuto il Porcellum con la destabilizzazione del Senato sulla stabilità del governo e sulla governabilità del paese.
L’Italicum, sommato alla riforma monocamerale rischia di avere effetti dirompenti. Infatti la maggioranza assoluta nella camera unica, per effetto del premio di maggioranza conseguito col 40% dei voti sul 60% dei votanti effettivi, scenderebbe di fatto al 24% degli aventi diritto al voto, col risultato di una 'verticizzazione' del potere politico che non giova a nessuna delle formazioni politiche in atto esistenti. E soprattutto non giova ai cittadini, che vedrebbero la formazione di una casta ancora più ristretta e inamovibile”.
E allora, in conclusione?
“In conclusione ci si deve chiedere se la riforma in senso monocamerale adottata sia idonea a risolvere i problemi istituzionali del Paese, o se non converrebbe mantenere il bicameralismo, riformando l’attuale senato in una camera con competenze differenti e diversamente composta, ma comunque concorrente nel procedimento legislativo. Il problema è grosso e richiede una profonda e specifica riflessione, al di là dei diversivi che si frappongono e che riguardano questioni che si sarebbero politici dovute affrontare nell’iter di approvazione della riforma, votata a larga maggioranza da entrambe le camere, invece di farne carico ai cittadini che nel referendum devono essere liberi di pronunciarsi sulla forma di stato che la legge costituzionale ha adottato e che, se confermata, produrrà i suoi effetti, al meno, per i prossimi cinquanta anni. C’è da dire che la stabilità del governo non è di per sé un valore e può anzi trasformarsi in un disvalore se non è preceduta dalla capacità di scegliere democraticamente un governo responsabile e competente. E, allo stesso modo, la rapidità delle decisioni legislative costituisce anch’essa un obiettivo valido, ma a condizione che le leggi siano giuste e idonee e che riforme definite epocali non debbano essere riformate dopo due anni come non di rado si deve constatare nella realtà quotidiana, perché altrimenti diventa essa stessa causa di ingovernabilità.
D’altra parte, la cronaca di questi giorni ci trasmette l’immagine di altri paesi europei, come Spagna e Lussemburgo, che paradossalmente crescono economicamente anche in mancanza di un governo stabile. In realtà, l’attuale semplificazione della selezione politica mette sempre maggiormente in rilievo la crisi di competenza della rappresentanza nelle istituzioni nazionali ed europee. L’improvvisazione, il pressappochismo, l’avventurismo, l’autoreferenzialità creano altrettanti guasti che la corruzione dilagante, che è quanto dire. A proposito del referendum non è male ricordare che al varo della Costituzione ha proceduto un’assemblea costituente in cui convergevano le più alte espressioni culturali delle forze politiche nate dal crollo dell’era fascista, mentre alla revisione costituzionale – nientemeno che del potere legislativo – si èproceduto unicamente a seguito di dibattito parlamentare tra forze politiche frazionate e configgenti, con inevitabili strumentalizzazioni tattiche che oggi rischiano di ripercuotersi sulla consultazione referendaria. Anche su questo i cittadini calabresi dovranno fermarsi a riflettere prima di esprimere il proprio consenso o dissenso alla riforma”.